Aumentano fame e povertà per un miliardo di persone Ancora pochi anni, appena sei, e la grande ipocrisia sarà svelata: gli «Obiettivi del Millennio» non saranno realizzati. Correva l’anno 2000 quando i 191 rappresentanti degli stati membri dell’Onu definirono i traguardi del Millenium Development Goal che avrebbe dovuto fare del mondo un posto più giusto entro il 2015. Tra gli svariati impegni c'era quello di dimezzare la popolazione mondiale che soffre la fame rispetto ai dati del 1990: in sostanza, passare dagli 842 milioni di 19 anni fa a circa la metà. Da allora sono trascorsi otto anni e la situazione, invece che migliorare, è decisamente peggiorata.
Ancora pochi anni, appena sei, e la grande ipocrisia sarà svelata: gli «Obiettivi del Millennio» non saranno realizzati. Correva l’anno 2000 quando i 191 rappresentanti degli stati membri dell’Onu definirono i traguardi del Millenium Development Goal che avrebbe dovuto fare del mondo un posto più giusto entro il 2015. Tra gli svariati impegni c'era quello di dimezzare la popolazione mondiale che soffre la fame rispetto ai dati del 1990: in sostanza, passare dagli 842 milioni di 19 anni fa a circa la metà. Da allora sono trascorsi otto anni e la situazione, invece che migliorare, è decisamente peggiorata.
Il nuovo rapporto della Fao, diventato ormai più un grido di dolore che un allarme, dimostra che la quota complessiva degli esseri umani sottonutriti invece di diminuire ha ripreso ad aumentare: ad oggi sfiora il miliardo. Il conteggio si ferma infatti a 963 milioni. Rispetto al 2007 altri 40 milioni di persone, quasi quanto l'intera popolazione della Spagna, è scivolata nel baratro della malnutrizione. Due anni fa erano addirittura 115 milioni in meno. E per questa situazione non si intravedono spiragli di miglioramento. Il bilancio potrebbe anzi precipitare nel breve periodo a causa della crisi finanziaria mondiale i cui effetti già si manifestano nell'economia reale. Il rapporto della Fao ci indica anche che il 65% degli affamati dell'intero globo vive in appena 7 paesi divisi tra Asia e Africa sud-sahariana, dove una persona su tre è cronicamente sotto la soglia di nutrizione. Si parla di stati come India, Cina, Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Etiopia, e Congo. Quest'ultimo ha fatto registrare l'aumento più significativo: dal 29% al 76% della popolazione a causa del perdurare dei conflitti interni. Inoltre negli ultimi mesi, in 25 stati sono scoppiate rivolte e sommosse per il cibo.
Ad aggravare l'emergenza è l'andamento dei mercati: quando le quotazioni dei prodotti alimentari sono alte i consumatori più poveri non possono permettersi la spese. Se invece i prezzi si abbassano sono i contadini che non riescono a sopravvivere. Non a caso anche Benedetto XVI, all'interno del suo tradizionale messaggio per la giornata della pace aveva esplicitamente dato la colpa della crisi alimentare alla speculazione dei mercati e non alle carenze produttive o al sovrappopolamento della Terra. Il pianeta può infatti produrre cibo per circa il triplo della sua popolazione attuale. Il problema resta l'attuale distribuzione tutta a favore dei paesi ricchi e le speculazioni meramente finanziarie che gonfiano i prezzi senza considerare gli effetti devastanti sulle popolazioni più povere. Secondo Hafez Ghanem, vicedirettore della Fao e curatore del rapporto, «se i costi alti e la stretta creditizia della crisi economica costringeranno gli agricoltori a diminuire la semina, l'anno prossimo potrebbe verificarsi un’ondata di prezzi alimentari alti ben peggiore di quella registrata nel 2008».
Per salvare gli affamati servirebbero 30 miliardi di dollari l'anno, poca cosa in confronto alle spese per gli armamenti o alle cifra stanziate per ammortizzare la crisi economica. Basti pensare che questa cifra equivale ad appena l'8% dei finanziamenti annuali dell'Ocse all'agricoltura. «È urgente favorire lo sviluppo dell'agricoltura nel Sud del mondo - dice Ghanem - nella direzione di una agricoltura locale sostenibile e non solo intensiva per l'esportazione». Questo è l'unico rimedio per contrastare il fenomeno a lungo termine. Perché, se è vero che i meccanismi di controllo delle emergenze del World Food Programme riescono, in genere, a togliere abbastanza in fretta dai telegiornali le immagini dei bambini scheletrici coperti di mosche o con la pancia piena d'aria, è anche vero che esiste un'altra fame ben più subdola. Non è quella che uccide in pochi mesi ma quella che, tanto più quando è cronica, nega a una fetta enorme dell'umanità le energie sufficienti a vivere e dunque schiavizza il pensiero, indebolisce il sistema immunitario e impedisce il lavoro. Distruggendo così le speranze e le reali possibilità di sviluppo di un Paese.
Di fronte al disastro, forse non è più tabù mettere in discussione sia il modello di sviluppo economico, sia il sistema di aiuto ai paesi del terzo mondo. E bisogna fare questo, non tanto per rispettare lo slogan degli obiettivi del millennio, slogan ormai quasi compromesso, ma per dare un futuro a più di un miliardo di persone.
[raffaele buscemi]
continua
CONFLITTO DI GAZA
Intervista a Nahum Barnea
 «Non ci sono dubbi che le operazioni militari organizzate da Israele sono state condotte ad ampio spettro. Il punto è che sono durate anche molto più a lungo di quanto ci si aspettasse», racconta da Gerusalemme Nahum Barnea, una delle penne più autorevoli del giornalismo israeliano, intervistato in esclusiva da m@g. Barnea, che scrive per il quotidiano Yedioth Ahronoth e ha vinto il premio Israel Prize per la comunicazione, ha perso un figlio nel 1996, in un attentato kamikaze di Hamas a un autobus di linea. Al funerale ha perdonato pubblicamente l’assassino, considerandolo vittima della stessa tragedia che affligge il popolo palestinese. Da anni si spende per favorire il dialogo nell’ambito del conflitto arabo-israeliano.
«Non ci sono dubbi che le operazioni militari organizzate da Israele sono state condotte ad ampio spettro. Il punto è che sono durate anche molto più a lungo di quanto ci si aspettasse», racconta da Gerusalemme Nahum Barnea, una delle penne più autorevoli del giornalismo israeliano, intervistato in esclusiva da m@g. Barnea, che scrive per il quotidiano Yedioth Ahronoth e ha vinto il premio Israel Prize per la comunicazione, ha perso un figlio nel 1996, in un attentato kamikaze di Hamas a un autobus di linea. Al funerale ha perdonato pubblicamente l’assassino, considerandolo vittima della stessa tragedia che affligge il popolo palestinese. Da anni si spende per favorire il dialogo nell’ambito del conflitto arabo-israeliano.
[viviana d'introno e cesare zanotto]
L'INTERVISTA
 Yang Lian, nato in Svizzera nel 1955 ma cresciuto a Pechino, è oggi uno dei maggiori poeti contemporanei e una tra le voci più importanti della dissidenza cinese. Esiliato dalla Repubblica Popolare Cinese dopo avere duramente criticato nel 1989 la repressione di Piazza Tiananmen, vive all’estero da vent’anni. È stato candidato al Premio Nobel nel 2002 e le sue poesie sono state tradotte in 25 lingue. Yang Lian interpreta lo spirito della millenaria cultura cinese attraverso la sua esperienza da esule. Una riflessione sulla condizione generale dell’uomo ma anche un invito alla speranza per milioni di cinesi che chiedono democrazia.
Yang Lian, nato in Svizzera nel 1955 ma cresciuto a Pechino, è oggi uno dei maggiori poeti contemporanei e una tra le voci più importanti della dissidenza cinese. Esiliato dalla Repubblica Popolare Cinese dopo avere duramente criticato nel 1989 la repressione di Piazza Tiananmen, vive all’estero da vent’anni. È stato candidato al Premio Nobel nel 2002 e le sue poesie sono state tradotte in 25 lingue. Yang Lian interpreta lo spirito della millenaria cultura cinese attraverso la sua esperienza da esule. Una riflessione sulla condizione generale dell’uomo ma anche un invito alla speranza per milioni di cinesi che chiedono democrazia.guarda l'intervista
[marzia de giuli e luca salvi]
L'INCHIESTA
 È un’emergenza che dura da oltre vent’anni. I territori tra Napoli e Caserta sono uno stato nello stato dove l’unico potere reale è quello della Camorra. Nonostante i blitz, gli arresti e l’invio di soldati e poliziotti, i clan continuano a fare affari in un cono d’ombra in cui convivono l’economia legale e la politica. Ne abbiamo parlato con Andrea Cinquegrani, direttore de La Voce della Campania (oggi La Voce delle Voci).
È un’emergenza che dura da oltre vent’anni. I territori tra Napoli e Caserta sono uno stato nello stato dove l’unico potere reale è quello della Camorra. Nonostante i blitz, gli arresti e l’invio di soldati e poliziotti, i clan continuano a fare affari in un cono d’ombra in cui convivono l’economia legale e la politica. Ne abbiamo parlato con Andrea Cinquegrani, direttore de La Voce della Campania (oggi La Voce delle Voci).
Ascolta l'intervista
[alberto tundo]
MARIO CAPANNA
Onda e '68 a confronto
 Quarant’anni dopo la protesta che ha segnato un’epoca, gli studenti italiani sono ancora in piazza. Secondo alcuni osservatori, l’Onda, che contesta la riforma Gelmini, è la fotocopia del’68. Altri la pensano diversamente. Mag ha chiesto un’opinione a Mario Capanna, ex studente dell’Università Cattolica e leader del movimento nel 1968.
Quarant’anni dopo la protesta che ha segnato un’epoca, gli studenti italiani sono ancora in piazza. Secondo alcuni osservatori, l’Onda, che contesta la riforma Gelmini, è la fotocopia del’68. Altri la pensano diversamente. Mag ha chiesto un’opinione a Mario Capanna, ex studente dell’Università Cattolica e leader del movimento nel 1968.
[cesare zanotto]
CIBO E MEMORIA

La relazione tra il cibo e la memoria è uno degli aspetti più profondi e antichi della cultura italiana e internazionale. Emblema di questo nesso è la madeleine che risveglia i ricordi dell’infanzia di Marcel Proust nel romanzo Alla ricerca del tempo perduto . Che cosa pensano i gourmet più affermati e i cuochi più celebri del nostro Paese del rapporto tra lo stile di vita dei nostri tempi e i cambiamenti nel gusto culinario, sempre più lontano dalla tradizione culinaria? La risposta nel servizio.
[francesco perugini]
GIORGIO BOCCA
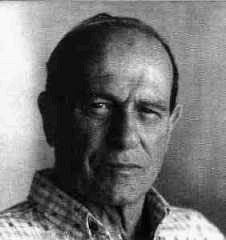
Nessuno meglio di Giorgio Bocca può aiutarci a riflettere sulla crisi che sta vivendo oggi la professione di giornalista. "E' la stampa, la bellezza!", il suo nuovo libro vuole essere un'occasione per riflettere sul destino di un mestiere che sembra aver perso le sue virtù. In Italia la carta stampata appare schiacciata dalle pressioni della politica e dell’economia, incapace di reagire allo strapotere della comunicazione televisiva, non più in grado di scandagliare i mutamenti reali della società. Abbiamo approfondito queste e altre questioni nell'intervista.
[gaia passerini]
RAPPORTO FAO
alle
29.1.09
0
commenti
![]()
Etichette: politica
CUBA
Giovane Castro, vecchio regime L’avvento di Raúl Castro al potere sembrava aver lasciato qualche spiraglio al raggiungimento di una maggiore libertà per i cubani. Poco dopo il suo insediamento ufficiale, avvenuto il 24 febbraio 2008, aveva dato inizio a una serie di riforme, come la possibilità di acquistare cellulari, schede telefoniche, computer, microonde, dvd dall’estero e addirittura di entrare negli alberghi e nei resort internazionali. A partire dal 2009, per i cubani sarà possibile comprare condizionatori, mentre dal 2010 potranno finalmente mangiarsi un toast. In realtà, tutte le promesse di Castro, mantenute o meno, sembrano essere più che altro uno specchietto per le allodole, in quanto nei due anni e mezzo del governo del fratello minore del líder máximo non c’è stato alcun miglioramento verso un pieno riconoscimento dei diritti umani, anzi. Secondo il rapporto annuale sulla libertà di stampa di Reporters sans Frontières , il 2007 attesta Cuba al 169esimo posto, soltanto cinque gradini sopra l’ultima classificata, l’Eritrea. Sono 24 i giornalisti rinchiusi nelle carceri, un numero che fa di Cuba la seconda prigione dei giornalisti dopo la Cina, mentre sono stati registrati 80 tra attacchi fisici, minacce e arresti. L’informazione sembra vivere ancora nel terrore della “primavera nera”, la terribile ondata di repressione che dal 18 al 24 marzo 2003 vide 90 tra giornalisti, sindacalisti e dissidenti arrestati e processati sommariamente: 75 i condannati, con pene dai 6 ai 30 anni di reclusione.
L’avvento di Raúl Castro al potere sembrava aver lasciato qualche spiraglio al raggiungimento di una maggiore libertà per i cubani. Poco dopo il suo insediamento ufficiale, avvenuto il 24 febbraio 2008, aveva dato inizio a una serie di riforme, come la possibilità di acquistare cellulari, schede telefoniche, computer, microonde, dvd dall’estero e addirittura di entrare negli alberghi e nei resort internazionali. A partire dal 2009, per i cubani sarà possibile comprare condizionatori, mentre dal 2010 potranno finalmente mangiarsi un toast. In realtà, tutte le promesse di Castro, mantenute o meno, sembrano essere più che altro uno specchietto per le allodole, in quanto nei due anni e mezzo del governo del fratello minore del líder máximo non c’è stato alcun miglioramento verso un pieno riconoscimento dei diritti umani, anzi. Secondo il rapporto annuale sulla libertà di stampa di Reporters sans Frontières , il 2007 attesta Cuba al 169esimo posto, soltanto cinque gradini sopra l’ultima classificata, l’Eritrea. Sono 24 i giornalisti rinchiusi nelle carceri, un numero che fa di Cuba la seconda prigione dei giornalisti dopo la Cina, mentre sono stati registrati 80 tra attacchi fisici, minacce e arresti. L’informazione sembra vivere ancora nel terrore della “primavera nera”, la terribile ondata di repressione che dal 18 al 24 marzo 2003 vide 90 tra giornalisti, sindacalisti e dissidenti arrestati e processati sommariamente: 75 i condannati, con pene dai 6 ai 30 anni di reclusione.
Tre sono stati i giornalisti espulsi nel 2007, con la scusa di aver dato nei loro articoli un’immagine negativa del Paese. A Cuba ci pensa Granma, il quotidiano ufficiale del regime castrista, a raccontare la verità, o meglio, a raccontare la verità più comoda ai fratelli Castro. Lo sanno bene i giornalisti cubani dissidenti, che per fare una minima controinformazione sono costretti a registrare le proprie testate online in Florida. Una delle poche voci del dissenso rimaste sul territorio cubano è quella della blogger Yoani Sanchez che, attraverso il suo blog Generacion Y, racconta ogni giorno la difficile realtà del suo paese. Tradotto in 15 lingue, il blog di Yoani è uno dei più famosi al mondo, tanto da avere conquistato il prestigioso premio del quotidiano El Pais Ortega y Gasset. Peccato che la blogger, però, non sia riuscito a ritirarlo: il regime, infatti, non le ha dato i permessi necessari per lasciare l’isola. Un milione i contatti che Generacion Y genera, tra i quali però difficilmente troveremo dei cubani residenti sull’isola: nonostante le aperture di Raúl Castro, sono pochissimi quelli che riescono ad accedere a internet. È forse per questo che il regime non ha ancora provveduto a oscurarlo, in quanto il suo impatto sulla popolazione è molto limitato e chiuderlo del tutto scatenerebbe grandi polemiche nel resto del mondo.
Un giornalista che ha vissuto sulla propria pelle la capacità del regime di imbavagliare i giornalisti stranieri è Gary Marx, corrispondente del Chicago Tribune che, insieme ad altri due colleghi, vide il suo permesso cancellato il 22 febbraio 2007 e fu costretto a lasciare il paese entro pochi giorni. «Ho vissuto a Cuba con mia moglie e i miei due figli dal 2002 al 2007. Dal primo momento che ho messo piede sull’isola, sapevo che avrei potuto essere espulso anche subito: un corrispondente della Reuters era stato allontanato soltanto pochi anni prima. Ma ho sempre pensato che avrei dovuto scrivere ciò che credevo fosse la verità, anche se questo avrebbe causato la mia espulsione. Gli ufficiali cubani mi chiamarono subito dopo il mio secondo o terzo articolo ed espressero rabbia e disprezzo verso il mio lavoro, ma ho continuato a scrivere, nonostante le pressioni fossero sempre presenti. Quello che il governo fa, con molto successo devo dire, è di obbligare i corrispondenti a censurarsi da soli piuttosto che affrontare la bomba mediatica di un’espulsione. Ho ragione di credere che il mio telefono e il mio ufficio fossero controllati dalla polizia. Sono stato trattenuto circa sei volte durante il mio ultimo anno a Cuba mentre lavoravo per i miei reportage. Eppure sono riuscito a sconfiggere la paura grazie anche a molte persone che mi sono state vicine».
Per Marx è stato sempre difficile raccontare la verità. «Cuba è uno stato di polizia dove non esiste libertà d’informazione e trasparenza da parte del governo e il popolo ha paura di esprimersi onestamente, soprattutto con uno straniero. Il regime spesso tira fuori delle statistiche sulla fantastica crescita economica o sulla bassissima mortalità infantile: peccato che non esista nessun modo di verificarle».
A fronte del pensiero di molti, sul fatto che Raúl Castro abbia instaurato un regime ancora più repressivo, Gary è convinto che sarà sempre più difficile per i giornalisti raccontare Cuba. Per Marx
«non è cambiato niente da quando Raúl è al potere, né per il popolo, né per i corrispondenti. Inoltre, i giornalisti stranieri sul territorio sono talmente pochi che si possono contare sulle dita di due mani. Ma sicuramente non potranno mai fare a meno della stampa straniera sul territorio perché senza di essa tutto quello che viene detto da Fidel o Raúl non sarebbe diffuso in tutto il mondo. Questo è molto importante per la leadership castrista».
Gary Marx non si sbilancia, però, sul successo di Yoani Sanchez. Quando gli chiediamo perché il regime non ha ancora chiuso il blog della giornalista, ci dice: «Per quello che ne so io, a Cuba niente è come sembra. Io sono stato tradito da una spia che per anni si era comportato come un giornalista dissidente. Detto questo, non conosco Yoani personalmente, ma ho letto il suo blog. Sono sicuro che il governo cubano conosce ogni sua mossa, ma forse pensa che permetterle di scrivere il suo blog porti più benefici che chiuderlo. Sono pochissimi i cubani che hanno accesso a internet, quindi ciò che scrive ha davvero un impatto molto limitato». Dunque, ci sarà mai libertà di opinione a Cuba, internet o no permettendo? «E chi lo sa? Dieci anni fa nessuno avrebbe mai pensato che un afroamericano avrebbe potuto essere eletto presidente degli Stati Uniti. Una risposta a questa domanda non è possibile nel futuro a noi vicino. Salvo imprevisti, il regime cubano rimarrà saldo, così come il partito unico».
[alessia lucchese]
continua
alle
28.1.09
0
commenti
![]()
Etichette: esteri, giornalismo
ANIMAZIONE
Due giri di valzer sotto una pioggia di piombo Il regista diventa protagonista della propria creazione, mentre il dramma di guerra viene declinato con l’innocenza del linguaggio dei classici del fumetto Made in Usa. Non solo un cartoon, ma qualcosa che va oltre, un mix vincente, ovvero un «documentario di animazione» vincitore di un Golden Globe e candidato agli Oscar. Questo è il ricordo: un flashback isterico di un soldato che danza tra i cecchini di Beirut sotto lo sguardo del defunto leader libanese Bashir Gemayel. Ari Folman però non ricorda. Dentro di sé rimane un vuoto. Lui ha combattuto in Libano nel 1982, lui sa di Sabra e Chatila, ma non ricorda. Quel che rimane nella memoria del regista è un buco nero latente, che ne ha eroso la coscienza per vent’anni e tutto a un tratto si è svegliato. È bastato l’incubo di un commilitone, l’ossessione di ventisei cani che, come demoni, ne invocano il nome per sbranarlo. Sono i fantasmi dei cani uccisi durante la campagna libanese, quando l’esercito israeliano cercava di villaggio in villaggio i bersagli palestinesi da catturare. I cani latravano all’arrivo dei soldati di Tsahal e gli obiettivi fuggivano. Prima dei palestinesi, dovevano essere eliminati i cani. È solo l’incipit della brutalità della guerra israelo-libanese del 1982.
Il regista diventa protagonista della propria creazione, mentre il dramma di guerra viene declinato con l’innocenza del linguaggio dei classici del fumetto Made in Usa. Non solo un cartoon, ma qualcosa che va oltre, un mix vincente, ovvero un «documentario di animazione» vincitore di un Golden Globe e candidato agli Oscar. Questo è il ricordo: un flashback isterico di un soldato che danza tra i cecchini di Beirut sotto lo sguardo del defunto leader libanese Bashir Gemayel. Ari Folman però non ricorda. Dentro di sé rimane un vuoto. Lui ha combattuto in Libano nel 1982, lui sa di Sabra e Chatila, ma non ricorda. Quel che rimane nella memoria del regista è un buco nero latente, che ne ha eroso la coscienza per vent’anni e tutto a un tratto si è svegliato. È bastato l’incubo di un commilitone, l’ossessione di ventisei cani che, come demoni, ne invocano il nome per sbranarlo. Sono i fantasmi dei cani uccisi durante la campagna libanese, quando l’esercito israeliano cercava di villaggio in villaggio i bersagli palestinesi da catturare. I cani latravano all’arrivo dei soldati di Tsahal e gli obiettivi fuggivano. Prima dei palestinesi, dovevano essere eliminati i cani. È solo l’incipit della brutalità della guerra israelo-libanese del 1982.
Il regista Ari Folman, seguito dello scenografo David Polonsky, dona uno sguardo nuovo su uno dei periodi più bui della storia d’Israele, lasciando un prodotto originale e comparabile con le tavole a fumetti concepite da Joe Sacco con Palestine alla fine degli anni Ottanta. Ma ha una forza in più. Oltre alla sola funzione documentaristica, preponderante nella produzione di Sacco, che oltre alla Palestina occupata ci ha portato anche l’esperienza dei Balcani, o al reportage del cartoonist canadese Guy Delisle Pyongyang, Folman indaga la psicologia dei reduci del fronte. La violenza emotiva con cui Folman travolge lo spettatore, nel caso del film, o il lettore, qualora si cimenti nella lettura delle tavole a fumetti ricavate dalla sceneggiatura del lungometraggio, è frutto della spinta mimetica del testimone oculare. La curiositas del Folman reduce, che ha rimosso le immagini dei cadaveri ammassati per i campi profughi dopo l’eccidio operato dai falangisti maroniti, è paragonabile a quella dello spettatore ignaro che vuole scoprire la verità. Così, a braccetto dello stesso regista, si entrerà in una dimensione psichedelica, dove il cartoon è un ingrediente amplificatore della violenza dei fatti narrati. Non serve quindi il D Day di Spielberg, o il Vietnam di Stone, a Folman bastano i tratti a china e i colori delle produzioni per bambini di Polonsky. Quella fame di verità verrà svelata di incontro in incontro, di reduce in reduce, tra i ricordi di ventenni armati e allo sbaraglio. L’unica certezza è che la danza scriteriata del soldato Shmuel Frenkel, agli occhi del poster di Bashir, è sinonimo che in guerra non esistono eroi, ma solo ragazzini incoscienti. L’ossimoro dell’innocenza del cartoon, unito al dramma della guerra, lascia senza parole.
Ma dietro all’incoscienza e alla disinformazione militare si cela il disastro. La forza di questa graphic novel è proprio la rilettura attraverso gli occhi degli stessi protagonisti, ma filtrata con adulta consapevolezza. Il rischio della visione di Valzer con Bashir, con la ferita ancora aperta di Gaza, potrebbe indurci a un’interpretazione spiccatamente pacifista, ma l’intento di Folman non è certo questo. Come spiega Paolo Mereghetti sul Corriere, questa lettura è da fugare perché il film «si interroga, e ci interroga, sulle “amnesie” che cancellano ogni volta l' orrore della violenza e spingono a riutilizzarla anche se ne dovremmo conoscere la sua inutilità. E perché, utilizzando i disegni invece delle riprese dal vero, si interroga anche sull' usura delle immagini e sul modo migliore di entrare in comunicazione con lo spettatore. Il tema centrale del film, infatti, è l' amnesia di cui si rende conto il regista dopo le confessioni di un amico sugli incubi che lo perseguitano e che risalgono con evidenza al suo servizio militare e alle azioni di guerra in cui fu coinvolto».
[francesco cremonesi]
continua
alle
28.1.09
0
commenti
![]()
Etichette: cinema
ESTERI
Bombe al fosforo: l’accusa a Israele Ritorna lo spettro delle bombe al fosforo per Israele. Inizialmente l’accusa era stata scagliata da alcuni blogger palestinesi, come Laila El-Haddad, che nel suo blog Raising Yusuf and Noor: diary of a Palestinian mother descrive minuziosamente le ferite riportate da alcuni pazienti ricoverati nell’ospedale di Shifa. Molti altri blog e siti web si sono occupati dell’argomento, corredando le accuse con foto di corpi straziati dagli effetti devastanti che le bombe al fosforo producono, fino a che anche Human Rights Watch e Amnesty International hanno alzato i toni della denuncia.
Ritorna lo spettro delle bombe al fosforo per Israele. Inizialmente l’accusa era stata scagliata da alcuni blogger palestinesi, come Laila El-Haddad, che nel suo blog Raising Yusuf and Noor: diary of a Palestinian mother descrive minuziosamente le ferite riportate da alcuni pazienti ricoverati nell’ospedale di Shifa. Molti altri blog e siti web si sono occupati dell’argomento, corredando le accuse con foto di corpi straziati dagli effetti devastanti che le bombe al fosforo producono, fino a che anche Human Rights Watch e Amnesty International hanno alzato i toni della denuncia.
Proprio Amnesty International, in un comunicato, ha dichiarato che i delegati in visita nella Striscia di Gaza «hanno riscontrato prove evidenti e incontestabili dell’uso massiccio di fosforo bianco in aree densamente popolate di Gaza City e in altre zone del nord della Striscia». Il tam-tam sul web si è amplificato in maniera tale da raggiungere anche gli organi di stampa. Il 5 gennaio il quotidiano inglese Times ha lanciato una pesante accusa nei confronti dell’esercito israeliano, contestandogli di aver fatto ricorso al fosforo bianco per coprire i movimenti delle truppe durante l’attacco del 4 gennaio. All’indomani dell’attacco alla sede dell’Unrwa, il 16 gennaio anche il The Guardian pubblica sul suo sito web un video che mostra alcuni feriti palestinesi curati nell’ospedale egiziano di Khan Yunis.
L’incubo del fosforo ritorna. A due anni e mezzo di distanza dallo scandalo della guerra in Libano, dove Israele fu costretta ad ammettere di aver fatto ricorso alle bombe al fosforo bianco, lo stato ebraico rischia ancora una volta di essere accusato di crimini di guerra. Lo dice infatti la Convenzione di Ginevra sulle armi chimiche, firmata il 10 ottobre del 1980: il terzo protocollo del trattato, all’articolo 2, vieta infatti «in qualsiasi circostanza attaccare con armi incendiarie la popolazione civile in quanto tale, i civili isolati o beni di carattere civile», a maggior ragione in una delle zone più densamente popolate del pianeta come la Striscia di Gaza. Eppure, fatta la regola, trovato l’inganno. Le norme internazionali non vietano l’utilizzo del fosforo bianco per illuminare il bersaglio o per schermare i movimenti delle proprie truppe. E così, nonostante i divieti, nelle guerre dell’ultimo decennio le bombe al fosforo sono state le armi più utilizzate: per primi gli Stati Uniti durante la seconda guerra del Golfo, a seguire Israele in Libano e adesso nella Striscia di Gaza.
Gli effetti delle bombe al fosforo bianco sono devastanti. Il Willy Pete, nome con cui viene soprannominato in gergo militare, se esposto all’ossigeno, crea un denso fumo bianco che brucia immediatamente a contatto con la pelle. Per i medici, le ferite da fosforo bianco sono molto difficili da curare poiché non smettono di bruciare finché le molecole non si sono esaurite del tutto, tanto che spesso riescono a corrodere la pelle fino alle ossa. Le bombe al fosforo sono utilizzate dagli eserciti fin dalla prima guerra mondiale, ma è soprattutto durante la guerra del Vietnam che ne viene fatto il suo uso maggiore. Una carneficina che tutti vollero scongiurare si potesse ripetere di nuovo sottoscrivendo la Convenzione di Ginevra. Ma è proprio il protocollo 3 sulle armi chimiche quello a creare più disaccordo, tanto da non essere stato firmato proprio dai due eserciti più potenti al mondo: Stati Uniti e Israele.
Il 21 gennaio il quotidiano israeliano Haaretz dà notizia di un’indagine aperta dal ministero della Difesa israeliano per verificare se Tsahal abbia fatto un uso improprio di bombe al fosforo bianco durante gli scontri di Gaza. La brigata su cui si sta svolgendo l’inchiesta avrebbe lanciato circa venti granate al fosforo nell’area nord della Striscia. L’esercito ha affermato che tali bombardamenti sono stati effettuati nel rispetto delle leggi internazionali. Eppure, le foto dei palestinesi feriti e uccisi da questi bombardamenti e le testimonianze dei superstiti continuano a fare il giro del mondo.
[alessia lucchese]
continua
alle
27.1.09
0
commenti
![]()
Etichette: esteri
RECESSIONE
2009: sarà un anno da dimenticare Ormai è certo, per l'economia il 2009 sarà un anno nero. Ad assestare il colpo di grazia all'ottimismo sono stati i dati Istat sulla produzione industriale dello scorso novembre: -12% rispetto allo stesso mese del 2007. Un dato che nelle previsioni di Bankitalia (confermate dalla Ue) farà sprofondare il Pil italiano di almeno due punti percentuale, 0,7 in meno di quanto già previsto dalle cassandre di Confindustria.
Ormai è certo, per l'economia il 2009 sarà un anno nero. Ad assestare il colpo di grazia all'ottimismo sono stati i dati Istat sulla produzione industriale dello scorso novembre: -12% rispetto allo stesso mese del 2007. Un dato che nelle previsioni di Bankitalia (confermate dalla Ue) farà sprofondare il Pil italiano di almeno due punti percentuale, 0,7 in meno di quanto già previsto dalle cassandre di Confindustria.
Sarà l'export (-5,5%) il comparto più colpito. Ma a soffrire saranno anche la domanda interna e gli investimenti (-7,3%). E mentre le famiglie italiane si troveranno a fare i conti con il rallentamento dei salari e col rischio disoccupazione – prevista per il 2009 all'8,4% (+ 1,7% rispetto al 2008) – le aziende dovranno fronteggiare «un progressivo inasprimento delle condizioni di prestito» dovuto alla crisi finanziaria dello scorso autunno. Se i vati della finanza guardano al futuro con occhio cupo, i cultori del passato evocano l’austerity degli anni ’70. Tuttavia – avvertono gli esperti – la crisi attuale potrebbe sprofondare a livelli imprevisti perché – spiegano – si innesta in un periodo congiunturale particolarmente difficile, dove le debolezze interne si acuiscono a causa delle oscillazioni internazionali. C’è quindi da chiedersi come evolverà la situazione, perché i dati previsionali di Bankitalia potrebbero essere ritoccati in negativo.
In Italia la preoccupazione sale. Anche per la finanza pubblica che potrebbe scontare una doppia tendenza: l'innalzamento della spesa, da un lato, ed un calo delle entrate dall’altro. A diminuire infatti saranno sia il gettito Ires ( imposta che grava sule imprese) sia quello proveniente dalle accise sul metano. C' è poi il fattore x dell'evasione fiscale «perché la tentazione sale con le difficoltà di reddito dei contribuenti». Non stupisce quindi un possibile incremento del debito pubblico che, nel 2009, dovrebbe raggiungere il 105% del Pil. Resta da vedere se il rallentamento dell'inflazione, che dal 3,5% del 2008 scenderà all’1,2%, favorirà la tenuta dei consumi.
I primi segni di ripresa vengono rimandati al 2010 quando il Pil dovrebbe segnare un timido + 0,5%. L’esortazione del presidente di Bankitalia Mario Draghi è «agire con ogni possibile iniziativa per attenuare e abbreviare la recessione». Le reazioni della politica paiono invece contrastanti. Se Walter Veltroni, leader del Pd, parla di «emergenza», Fabrizio Cicchitto del Pdl replica alle accuse di immobilismo. Intanto però, con un rapporto deficit – Pil stimato al 3,8%, l’Italia rischia ancora di non rispettare i parametri di Maastricht.
[ivica graziani]
continua
alle
23.1.09
0
commenti
![]()
WEB E SOCIETÁ
Innocentievasioni.net il carcere è on line Le mura del carcere tracciano un confine preciso. Su cui persino l’immaginazione s’infrange.
Le mura del carcere tracciano un confine preciso. Su cui persino l’immaginazione s’infrange.
Circoscrivono un universo silente, talmente complesso da rischiare di essere banalizzato. É il luogo “delle libertà possibili” ( talvolta negate) che accompagnano la quotidianità detentiva. Dove le speranze si scontrano con le privazioni e le privazioni si consolano con le speranze. Contraddizioni, potenzialità rimosse, che meriterebbero di essere raccontate. Innocentievasioni.net è nato con questo obiettivo: avvicinare due mondi.
«Dei luoghi detentivi -osserva Luigi Manconi, già sottosegretario alla Presidenza del governo Prodi e direttore del sito con Patrizio Gonnella - abbiamo un’immagine deformata che ci proviene da racconti parziali. C'è la necessità di oltrepassare il punto di vista della pena e dell’ordine pubblico. Perché il carcere non è solo un luogo di mortificazione, al suo interno sboccia una domanda formidabile di comunicazione cui bisogna rispondere”. Per Manconi, ll’attenzione al problema prima ancora che politica, è umana, nata da una vicenda che si perde nell’adolescenza. “Avevo 15 anni. – racconta- Feci un viaggio con un detenuto che aveva i polsi ammanettati. Riamasi colpito. Credo che questo episodio abbia condizionato per sempre il mio atteggiamento verso la privazione della libertà».
Il sito, che ad una settimana dal lancio si è già dimostrato un autorevole spazio di denuncia, darà voce ad esperti ed addetti ai lavori. Ma soprattutto attiverà corrispondenze tra i “liberi” e i reclusi, offrendo un canale alle tante pagine di letteratura carceraria. «I contatti – confida soddisfatto il direttore - sono stati già numerosi e per il futuro immaginiamo un flusso continuo di comunicazione». Innocentievasioni cercherà così di attirare l'attenzione dei navigatori sui diritti negati ai reclusi.“A livello istituzionale- sottolinea il direttore - il carcere prevede la privazione della sola libertà di movimento. Nei fatti però la maggior parte dei diritti viene sospesa durante la detenzione. Dei 60 mila detenuti, ad esempio, sono solo poche centinaia ad esercitare il diritto di voto. E se nel nostro codice non esiste alcun divieto all'affettività o alla sessualità nei fatti queste mutilazioni ci sono e vanno viste come una conseguenza del nostro sistema carcerario. Anche il diritto al lavoro non viene quasi mai soddisfatto”. Sarà forse per questi motivi che il numero dei suicidi dietro le sbarre risulta superiore alla media nazionale?
“ Purtroppo- conclude Manconi- invece di elaborare sanzioni alternative alla detenzione, in Italia l'unica questione che viene posta è quella relativa alla costruzione di nuove strutture detentive”. Con casi che sfiorano il ridicolo. Un esempio? Il carcere di Gela progettato nel ’59 ed ancora da inaugurare.
[ivica graziani]
continua
alle
23.1.09
0
commenti
![]()
TEATRO ALLA SCALA
Musica per la pace  La West-Eastern Divan Orchestra porta il suo messaggio di pace alla Scala. Mai così necessario come negli scorsi giorni di conflitto a Gaza. Ovest ed est, infatti, caratterizzano fin dall’inizio questa compagine orchestrale, nata in Europa, a Siviglia, dieci anni fa, per volere del maestro argentino-israeliano Daniel Barenboim e dello scrittore palestinese Edward Said. Un ensemble che mette a confronto giovani musicisti provenienti dal Medio Oriente, israeliani e arabi. Un confronto tra le due culture a suon di note, per superare atavici e storici conflitti. Barenboim, che dall’anno scorso ha ricevuto la cittadinanza onoraria palestinese, è sempre stato conscio del valore della sua orchestra, che «non può decidere la pace – ripete spesso – ma può creare le condizioni per una comprensione senza la quale è impossibile il dialogo».
La West-Eastern Divan Orchestra porta il suo messaggio di pace alla Scala. Mai così necessario come negli scorsi giorni di conflitto a Gaza. Ovest ed est, infatti, caratterizzano fin dall’inizio questa compagine orchestrale, nata in Europa, a Siviglia, dieci anni fa, per volere del maestro argentino-israeliano Daniel Barenboim e dello scrittore palestinese Edward Said. Un ensemble che mette a confronto giovani musicisti provenienti dal Medio Oriente, israeliani e arabi. Un confronto tra le due culture a suon di note, per superare atavici e storici conflitti. Barenboim, che dall’anno scorso ha ricevuto la cittadinanza onoraria palestinese, è sempre stato conscio del valore della sua orchestra, che «non può decidere la pace – ripete spesso – ma può creare le condizioni per una comprensione senza la quale è impossibile il dialogo».
Il nome della West-Eastern Divan Orchestra fu ricavato da una raccolta di poesie di Goethe, l’unica pubblicata mentre il Dante germanico era in vita. Il “Divan occidentale-orientale” è infatti un poema in cui cultura europea e del Vicino Oriente si parlano, come avviene nell’orchestra.
E allora, musica, maestro Barenboim, nel tempio milanese! Qui, il pubblico parrebbe quello di una prima verdiana assoluta. Una sciura rimprovera al maestro i 5 minuti di attesa, oltre le previste nove di sera. E sì che già due concerti si sono susseguiti nella giornata. Palco già rodato e pubblico inghingherato. Binocoli, scialli, pellicce e spartiti scrutano i primi orchestrali. In programma Mozart, Schönberg, Brahms. Il Concerto per tre pianoforti Kv 242 che Mozart scrisse a 20 anni per la contessa salisburghese Lodron e le sue due figliole, è un capolavoro di esecuzione. Barenboim interpreta la parte scritta da Wolfgang per la contessina più giovane e dirige a est e ovest l’orchestra dall’organico settecentesco, mentre di fronte a lui duettano Karim Said, palestinese, e Yael Kareth, israeliana. Il secondo movimento raccoglie più di un assenso nel pubblico, e la riproposizione di un tema sembra già preludere alla forma dei tre brani scelti: la ripetizione e la variazione. Come la guerra che non ha sosta e si ripete. Ma anche come la speranza, che va verso la rinascita di nuova vita, di un nuovo tema che continuerà.
A Mozart segue Schönberg, di cui la West-Eastern Divan fa ascoltare le Variazioni per orchestra op. 31. Si tratta del primo brano orchestrale in cui fu usato il sistema dodecafonico, 1926-28. Gli archi riescono a far vibrare tutti i suoni della serie sparsi nel brano. E le variazioni si succedono in fila, le quattro serie dodecafoniche a fare da trama e ordito. Infine – e i maniaci dello spartito si slanciano quasi oltre il parapetto – l’immortale Quarta sinfonia di Johannes Brahms, composta nel 1884-85, a un anno dalla morte di Wagner. Qui Barenboim esibisce la propria cultura bayreuthiana, spingendo gli archi in un afflato tetralogico, i legni in certe frasi vellutate alla “Lohengrin”. Ma Brahms era lontano da Wagner, e Barenboim ci ricorda nella sua interpretazione quale sia il suo padre putativo, Ludwig Van Beethoven. Attraverso le variazioni (36) dell’ultimo movimento, una vera e propria passacaglia, il musicista di Bonn ci è svelato a poco a poco, su un basso ostinato di una cantata di Bach. Ma Brahms va oltre Beethoven, va oltre Wagner. Verso la metà del quarto movimento – due legni risuonanti – Barenboim riposa, solo lo sguardo dirige. Non fosse per qualche esagerazione ostentata dai corni, questa esecuzione sarebbe stata pari a quelle storiche di Carlos Kleiber e Herbert von Karajan.
E il nostro pubblico, nel complesso? Qualcuno si aspetta un comizio. “Ma questa è musica e la musica è musica, non politica”, osserva una loggionista. E nessuna parola verrà spesa invano. Solo un “bravi” a metà serata, subito rintuzzato da un subitaneo “vedremo”: fate il vostro lavoro e avrete il plauso, alla meneghina. Gli applausi in realtà son pure troppi: irrompono tra i movimenti e alla fine addirittura si sovrappongono alle ultime note della sinfonia della “Forza del destino”. Ed è trionfo. Un violinista arabo di 12 anni fa capolino in questo bis verdiano: la forza del destino e il suo futuro.
[luca salvi]
continua
alle
23.1.09
0
commenti
![]()
SAGGIO
Un pezzo a me, uno a te: come ti spartisco l'Italia Lottizzare, ovvero dividere in lotti. Lotto: ognuna delle parti in cui un tutto viene diviso; in particolare, appezzamento di terreno corrispondente a una determinata unità edilizia. Insomma, cosa c’entra un termine derivato dall’edilizia con le estensioni della politica italiana? Lottizzazione della Rai, della sanità e chi più ne ha ne metta. L’etimologia della parola non lascia scampo a equivoci, ma ci pone davanti a un quesito fondamentale. Il Belpaese è lottizzato? Ovvero, è suddiviso, spartito, ritagliato, quotato e assegnato alla gestione di qualcosa o qualcuno?
Lottizzare, ovvero dividere in lotti. Lotto: ognuna delle parti in cui un tutto viene diviso; in particolare, appezzamento di terreno corrispondente a una determinata unità edilizia. Insomma, cosa c’entra un termine derivato dall’edilizia con le estensioni della politica italiana? Lottizzazione della Rai, della sanità e chi più ne ha ne metta. L’etimologia della parola non lascia scampo a equivoci, ma ci pone davanti a un quesito fondamentale. Il Belpaese è lottizzato? Ovvero, è suddiviso, spartito, ritagliato, quotato e assegnato alla gestione di qualcosa o qualcuno?
La risposta non può che essere, ahimè, positiva. In soccorso, però, viene una lettura illuminante, L’elogio della lottizzazione (Saggi tascabili Laterza) di Paolo Mancini, docente di Comunicazione all’Università di Perugia e alla Luiss di Roma. La spartizione dei poteri da parte delle forze politiche del Paese è un dato di fatto assodato da tempo. La Rai è, infatti, il più grande esempio di questo processo di falsa coscienza marxiana; resta dunque da chiedersi quale sia il movente che abbia spinto Mancini a comporre un saggio su una questione arcinota. Scrive Mancini nell’introduzione al volume: «Tutti condannano la lottizzazione; ma tutti, in misura maggiore o minore, ancora la praticano? Perché? Non vale forse la pena di indagare le ragioni di questa inesorabile presenza e possibile falsa coscienza?». L’intento di Macini dunque è proprio quello di entrare nei meandri, non solo negativi, del fenomeno: «Sì, un processo alla lottizzazione. Questo è quello che voglio fare, con tanto di avvocato difensore e pubblica accusa». Il titolo del libro è chiaramente una provocazione di sottile ironia, eppure sembra che nel dna del politico della seconda Repubblica sia ormai radicato profondamente il gene lottizzatore. Come notava, ironicamente, Giovanni Belardelli sul Corriere della Sera il 16 gennaio scorso, la signora Mastella ha addirittura rimproverato al marito l’assegnazione di un posto da primario di ginecologia a un medico di Forza Italia. Ma dove vogliamo andare se perfino gli uteri seguono le ragioni di partito?
Sicuramente ci può essere un velo di compassione nell’analisi del fenomeno lottizzatorio. Con la discesa in politica del Cavaliere, a braccetto col suo conflitto di interessi, è probabile che il fenomeno lottizzatorio venga letto con un tacito assenso pluralistico dei canali informativi. Ma Mancini scava ancora più a fondo nella questione e pone come punto di partenza il 1987, con un racconto tratto a sua volta da Senza rete di Angelo Guglielmi. Secondo gli autori, l’era della lottizzazione ebbe inizio una sera in un ristorante romano vicino al centro quando Walter Veltroni, allora responsabile dei problemi televisivi del Pci, Biagio Agnes, direttore generale della Rai ed Enrico Manca, presidente del consiglio d’amministrazione di viale Mazzini, trattarono la facoltà di designazione di un direttore di rete al Pci. Fu il punto di non ritorno. Già. Perché, se da principio motore ci potrebbe essere la pulsione pluralistica, l’incancrenirsi del fenomeno lo ha ricoperto di accezioni patologiche irreversibili. Però, se la lottizzazione ha colpito di tutto un po’, il fiore all’occhiello rimane la questione della Rai. Scrive Mancini nel primo capitolo: «Lottizzare la Rai significa non solo controllare risorse e distribuire ai propri clientes, come avveniva nel caso di qualsiasi altra azienda o amministrazione pubblica, ravvivando così il clientelismo e la partitocrazia, ma significa anche agire su una delle leve principali della democrazia: il consenso». Insomma, la Rai è il sancta sanctorum del «prendere due piccioni con una fava». Vale a dire, da un lato si ottempera alla necessità di partito, dall’altra si va dritti al cuore dell’opinione pubblica: l’influenza mediatica.
[francesco cremonesi]
continua
alle
22.1.09
0
commenti
![]()
REGIONE LOMBARDIA
Lavoratori a rischio, presidio in via Filzi “I soldi sono pochi, e nun se po’ campà”, recita uno dei volantini distribuiti dai membri del presidio (piuttosto esiguo) riunitosi il 16 gennaio davanti alla sede della Regione Lombardia di via Filzi. I rappresentanti del sindacato Confederazione Unitaria di Base (Cub) e della Borghi Trasporti, società del gruppo Bartolini con sede a Vimercate, si sono dati appuntamento per valutare le misure contro la crisi economica. «La Borghi trasporti è in crisi - racconta uno dei dipendenti -. Tutto il settore è in mano a cooperative, ma ormai la manodopera a basso costo ha messo in forse molti posti di lavoro».
“I soldi sono pochi, e nun se po’ campà”, recita uno dei volantini distribuiti dai membri del presidio (piuttosto esiguo) riunitosi il 16 gennaio davanti alla sede della Regione Lombardia di via Filzi. I rappresentanti del sindacato Confederazione Unitaria di Base (Cub) e della Borghi Trasporti, società del gruppo Bartolini con sede a Vimercate, si sono dati appuntamento per valutare le misure contro la crisi economica. «La Borghi trasporti è in crisi - racconta uno dei dipendenti -. Tutto il settore è in mano a cooperative, ma ormai la manodopera a basso costo ha messo in forse molti posti di lavoro».
Dopo l’acquisizione della Borghi da parte del gruppo Bartolini, i lavoratori sono stati dirottati a Vimercate, comune per il quale era in progetto un piano di reindustrializzazione. «Ma la reindustrializzazione non c’è stata - prosegue amaramente il dipendente -, anche se Vimercate è da sempre un polo industriale d’eccellenza. Al contrario, i lavoratori della Borghi sono stati messi in cassa integrazione, che la ditta non paga nemmeno con regolarità. Tra due mesi il periodo di cassa finirà, e noi non sappiamo più a che santo votarci». Un problema di sopravvivenza per le famiglie, soprattutto per quelle monoreddito, con coniugi separati, o gravate da mutui. Si tira la cinghia e, perfino per venire a protestare a Milano, c’è chi ha dovuto chiedere i soldi in prestito per il biglietto del treno.
Intanto, nelle sale della Regione si apre il dibattito per valutare e approfondire le misure che verranno attuate per far fronte alla crisi economica. Tra fondi regionali, del governo e comunitari, circa 15 milioni verranno impiegati nel settore turistico, un centinaio per l’artigianato, 54 milioni nell’agricoltura, 187 nell’industria, con l’obiettivo di potenziare la competitività, l’innovazione, i nuovi progetti in questi settori. A destare preoccupazione sono soprattutto i contraccolpi della crisi finanziaria sul settore artigianale e sull’area di Malpensa. Per quanto riguarda l’artigianato, l’assessore Domenico Zambetti sottolinea che in Lombardia si trova un quarto delle imprese italiane: 270 mila aziende per 700 mila lavoratori. «Sostenere l’artigianato in Lombardia significa creare un volano per tutta l’Italia», precisa l’assessore. «Siamo consci che si tratti di un momento delicato, ma potremo superarlo se ci sarà unità di intenti tra la Regione e tutti gli enti territoriali della Lombardia». La situazione è preoccupante anche perché le aziende lombarde, da 8 o 9 dipendenti in media, sono molto snelle e flessibili, ma hanno difficoltà ad accedere al credito. Accade così che alcune di esse si trovino in crisi per soli 20 o 30 mila euro. «La Regione Lombardia dovrebbe aprirsi in questo senso», conclude Zambetti.
Su Malpensa si pronuncia il vice presidente della giunta regionale Gianni Rossoni, secondo il quale la crisi finanziaria è destinata ad avere un ulteriore impatto sui piani Cai e Sea con altri contraccolpi sull’area di Malpensa. «Bisognerà soffrire ancora un anno o due prima del rilancio di Malpensa», profetizza Rossoni. «Tolti i 5,3 milioni di euro utilizzati ad oggi per i 600 lavoratori in cassa integrazione, restano ancora circa 31 milioni di euro di risorse stanziate disponibili». La Regione Lombardia è giunta alla sottoscrizione di un accordo con le parti sociali per l’utilizzo in chiave anticrisi delle risorse residue destinate a Malpensa; si attende il consenso delle province di Milano e Varese. Si sta cercando inoltre di favorire un accordo con il Governo perché ulteriori risorse vengano destinate all’assistenza e alla formazione dei lavoratori a tempo determinato e a progetto, oltre che di quelli a tempo indeterminato. «La Regione Lombardia è la più potente d’Italia e deve reagire», afferma Rossoni.
«ll problema principale, però, resta: i lavoratori non riescono ad arrivare a fine mese», spiega un sindacalista della Cub, dal presidio all’esterno del palazzo della Regione. «Noi siamo qui a chiedere che i cassaintegrati vengano reinseriti in altre posizioni con i contratti di solidarietà, che le indennità di cassa integrazione vengano portate all’80% dei salari, e che soprattutto vengano pagate regolarmente». Si chiede inoltre un dialogo col Governo affinché gli ammortizzatori sociali vengano estesi anche alle forme di lavoro precario. Dall’incontro in Regione, pare emergano tutte le buone intenzioni possibili per far fronte alla crisi. Ma il sindacalista Cub mette le mani avanti: «Ora vorremmo vedere anche i fatti».
[floriana liuni]
continua
alle
22.1.09
0
commenti
![]()
UNIVERSITÁ
Venezia riapre la polemica sulle honoris causa In un articolo del 14 gennaio sul Corriere della Sera, Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella hanno portato alla ribalta la Facoltà di Economia dell’università Cà Foscari di Venezia, che intendeva laureare ad honorem l’imprenditore trevigiano Giancarlo Zacchello. La motivazione era il finanziamento della Facoltà con 800mila euro di denaro pubblico, da elargire in otto anni, accordato da Zacchello in qualità di presidente dell’Autorità Portuale della laguna. L’università Cà Foscari non ha riconosciuto l’onorificenza, ma nega qualsiasi relazione della decisione con l’articolo, ricordando che il riconoscimento è previsto a studiosi di altissimo livello internazionale o a figure distinte del mondo economico e imprenditoriale, «come nel caso in discussione». Se non fosse che Zacchello ha finanziato l’università con denaro pubblico e non di tasca propria, contestano i due giornalisti.
In un articolo del 14 gennaio sul Corriere della Sera, Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella hanno portato alla ribalta la Facoltà di Economia dell’università Cà Foscari di Venezia, che intendeva laureare ad honorem l’imprenditore trevigiano Giancarlo Zacchello. La motivazione era il finanziamento della Facoltà con 800mila euro di denaro pubblico, da elargire in otto anni, accordato da Zacchello in qualità di presidente dell’Autorità Portuale della laguna. L’università Cà Foscari non ha riconosciuto l’onorificenza, ma nega qualsiasi relazione della decisione con l’articolo, ricordando che il riconoscimento è previsto a studiosi di altissimo livello internazionale o a figure distinte del mondo economico e imprenditoriale, «come nel caso in discussione». Se non fosse che Zacchello ha finanziato l’università con denaro pubblico e non di tasca propria, contestano i due giornalisti.
Normalmente le lauree honoris causa vengono conferite per opere compiute o per pubblicazioni fatte a persone note per la singolare perizia in determinate discipline. Giovanni Bogliolo, rettore da otto anni del grande ateneo di Urbino, spiega che anche le università ne beneficiano: «Nel momento in cui una importante personalità accetta un riconoscimento simile, la qualifica con il suo stesso nome: le Università vivono di questi rapporti. Niente di male se si instaura un rapporto attivo fra università e imprenditori-benefattori. Certo il titolo si svaluta se il beneficio diventa oggetto di contrattazione». Ricordando le lauree conferite a Sepulveda e a monsignor Ravasi, Bogliolo spiega anche la decisione di laureare “the doctor” Valentino Rossi, nel 2005: «La nostra facoltà di Sociologia ha ritenuto che Valentino aveva le caratteristiche che i nostri studenti di Comunicazione e Pubblicità per le Organizzazioni devono avere. Altre grandi università stavano per dargli persino una laurea in Ingegneria. Ma per noi aveva un valore aggiunto perché si tratta di un genius loci». Nessuno scandalo dunque: «L’università di oggi non è più il mondo dell’accademia, una camera stagna, ma ha attinenze con il sociale e quindi materie nuove. Fermo restando che il successo di un ateneo si misura a distanza di anni con la qualità dei laureati e delle pubblicazioni. Escludo che qualsiasi laurea ad honorem venga data per fini di visibilità. La laurea a Valentino non ci ha dato né tolto iscritti».
Diverso è il punto di vista di Alberto Castoldi, rettore a Bergamo dal 1999: «Sicuramente l’ondata di qualche anno fa è passata, ma per noi la laurea honoris causa rimane uno strumento per cercare consenso nel territorio, in un rapporto di legittimazione reciproca con le figure più eminenti». La laurea honoris causa è un atto che assume significati diversi a seconda dell’ambiente: «Laureare Giampiero Pesenti di Italcementi, grossa realtà locale, è una legittimazione che a Milano si perderebbe. Ma come strumento per segnalare la propria rilevanza come istituzione nel Paese sono meglio personaggi di richiamo nazionale. D’altronde, noi abbiamo laureato Andrew Viterbi, italoamericano di origini bergamasche, uno dei padri del telefonino, che nessuno aveva considerato. Se poi a Milano la Iulm laurea Vasco Rossi, sa bene cosa sta facendo. Diverso sarebbe se lo facesse la Statale». Il processo di assegnazione dura circa un anno e all’insaputa dell’interessato. Ma l’università non è l’unica via per poter scrivere “dottore” sul proprio biglietto da visita: su internet circolano infatti siti che assicurano “lo svolgimento di pratiche in forma strettamente riservata per il conseguimento di lauree honoris causa presso istituti italiani e stranieri”. Chissà se conviene fidarsi.
[daniele monaco]
continua
alle
21.1.09
0
commenti
![]()
TEATRO
Quella Praga alchemica, secondo Ronconi La lezione di Janàček è tutta nelle parole della protagonista: «È atroce sopravviversi. Se sapeste com' è leggera la vita per voi! Siete vicini a tutto. Per voi tutto ha un senso. Tutto ha valore per voi. Sciocchi, siete felici per la ragione che presto morirete». Questo messaggio, forte ed estremo, racchiude il valore dei giorni presenti, nella vita dell’uomo contemporaneo, con o senza qualità, e la necessità di viverli con rispetto e consapevolezza.
La lezione di Janàček è tutta nelle parole della protagonista: «È atroce sopravviversi. Se sapeste com' è leggera la vita per voi! Siete vicini a tutto. Per voi tutto ha un senso. Tutto ha valore per voi. Sciocchi, siete felici per la ragione che presto morirete». Questo messaggio, forte ed estremo, racchiude il valore dei giorni presenti, nella vita dell’uomo contemporaneo, con o senza qualità, e la necessità di viverli con rispetto e consapevolezza.
In questo affaire lo scenario è fatto di librerie in bilico: uno scatto sembra immortalarle prima che rovinino sui protagonisti. Ci troviamo nello studio legale dell’avvocato Kolenaty: due famiglie, i Prus e i Gregor, si contendono un’antica eredità. La situazione sembra sfavorevole per i Gregor; infatti, l’erede Albert teme la rovina. La matassa legale appare intricata, ma quando arriva in scena Emilia Marty, soprano misterioso e affascinante, la trama si carica di valenze simboliche. L’ipnotica donna sembra infatti conoscere alla perfezione il passato delle due famiglie ed è l’unica a sapere il luogo dove si trova l’antico testamento.
Emilia Marty, la cui figura magnetica cattura l’anima di tutti i personaggi, è una presenza transtemporale. Il suo fascino seduce e uccide, come avviene per il giovane fidanzato di Kristina, la figlia del commesso dello studio legale Vitek, che si toglie la vita per lei. Oppure come succede all’eccentrico Hauk-Sendorf, che vede in Emilia la sua antica fiamma gitana, Emilia Montez, da lui amata cinquant’anni prima. Quando la Marty sembra davvero sapere troppo, finisce per essere considerata pazza. Solo quando la fine si avvicina, decide di svelare la sua vera storia.
Il suo nome è Elina Makropulos, nata a Creta nel 1585. Suo padre, medico personale dell’imperatore Rodolfo II, aveva preparato un elisir che prolungasse la vita fino a trecento anni e l’aveva sperimentato su di lei. Elina diviene una creatura dalle molte identità, costretta a vivere la morte degli affetti più cari per generazioni. L’anima di Elina si fa pietra: una necessità, per proteggersi dai dolori e dalle emozioni delle diverse esistenze. Così appare cinica e glaciale, ma non è così. L’effetto della pozione sta per finire, ed è per questo che Emilia-Elina cerca disperatamente il testo greco con l’antica ricetta.
Improvvisamente si guarda allo specchio e si rende conto che una vita così le è insopportabile. Decide così di rinunciare all’immortalità ed è allora che i suoi sentimenti affiorano davvero. La scena finale, resa possibile dall’agilità degli interpreti, prevede una trasformazione fisica a scena aperta: la bellissima diva si ritrova d’un tratto canuta e stanca ad affrontare la morte.
La partitura del ceco, squadernata dall’orchestra nella direzione essenziale di Marko Letonja, racconta in dissonanze drammatiche l’animo cupo e ombroso di Elina, ma si fa leggera e distesa a tratti, come i ricordi più cari. Come nella Metamorfosi di Kafka, qui ogni gesto musicale ci parla della molteplicità delle vite, e della loro capacità di trasformarsi, anche repentinamente, senza dimenticare un riferimento, nemmeno troppo nascosto – un’installazione video che riproduceva in serie il volto della protagonista, ormai anziana – al Dorian Gray di Wilde, e al timore del tempo che passa e della bellezza caduca.
Ed è qui che si avverte la densità dei simboli dell’opera, palpabile anche nell’atmosfera in sala di questo debutto scaligero e nella scelta di un’illuminazione scenica plumbea e nebbiosa. I protagonisti, in primo luogo l'intensa Angela Denoke, non si sono risparmiati nemmeno sul palco delle prove, dimostrando di essere in piena voce, unita a un’intensa presenza scenica. La regia del maestro Luca Ronconi, senza forzature o intrusioni eccessive, ha seguito senza scossoni il dispiegarsi della trama, davvero paradossale. Una Praga alchemica, quasi inquietante, capitale di un Est europeo dove simboli e magia scivolano nel quotidiano. Irresistibile sortilegio, anche per scettici irriducibili.
[vesna zujovic]
continua
alle
19.1.09
0
commenti
![]()
MEDICINA ALTERNATIVA
Aghi e infusi contro i danni da chemio-terapia «Era ora che si cominciassero a curare anche le persone oltre che le malattie». Con queste parole Gianluca Magi, docente di culture orientali all’università di Urbino, esprime il suo entusiasmo riguardo all’iniziativa, presa dall’ospedale di Merano, di sperimentare alcune cure “alternative” sui malati di cancro. Agopuntura, fitoterapia, omeopatia, yoga e tai-chi non andranno a sostituire le terapie tradizionali ma aiuteranno a combattere i danni collaterali provocati da queste ultime. In Alto Adige l’80% dei malati di cancro già utilizza questi trattamenti. Secondo diverse testimonianze, i pazienti avrebbero trovato, in queste antiche pratiche orientali, un efficace rimedio contro i disturbi gastrointestinali da chemioterapia e i dolori post-operatori. «La medicina occidentale – spiega Magi – nasce dalla dissertazione dei cadaveri. Questo ha portato i medici allopatici a considerare il corpo umano come una macchina da aggiustare. Invece, la medicina cinese e quella ayurvedica partono dall’essere vivo e quindi, per queste, è impossibile prescindere da una concezione olistica della diagnosi e della cura».
«Era ora che si cominciassero a curare anche le persone oltre che le malattie». Con queste parole Gianluca Magi, docente di culture orientali all’università di Urbino, esprime il suo entusiasmo riguardo all’iniziativa, presa dall’ospedale di Merano, di sperimentare alcune cure “alternative” sui malati di cancro. Agopuntura, fitoterapia, omeopatia, yoga e tai-chi non andranno a sostituire le terapie tradizionali ma aiuteranno a combattere i danni collaterali provocati da queste ultime. In Alto Adige l’80% dei malati di cancro già utilizza questi trattamenti. Secondo diverse testimonianze, i pazienti avrebbero trovato, in queste antiche pratiche orientali, un efficace rimedio contro i disturbi gastrointestinali da chemioterapia e i dolori post-operatori. «La medicina occidentale – spiega Magi – nasce dalla dissertazione dei cadaveri. Questo ha portato i medici allopatici a considerare il corpo umano come una macchina da aggiustare. Invece, la medicina cinese e quella ayurvedica partono dall’essere vivo e quindi, per queste, è impossibile prescindere da una concezione olistica della diagnosi e della cura».
Queste tematiche, in Italia, sono state portate al grande pubblico da Tiziano Terzani: un giornalista che, nel libro Un altro giro di giostra, ha raccontato la sua esperienza con il cancro, affrontata sperimentando tutti i limiti della medicina occidentale e l’aiuto delle cure alternative. Terzani chiamava i medici di New York che lo avevano in cura “gli aggiustatori”, termine che il professor Magi trova particolarmente azzeccato. «Anche se in Italia i dati clinici sono ancora pochi – spiega l’orientalista – negli Usa e in Germania la sperimentazione di molte pratiche indo-cinesi dura ormai da 30 anni. Per esempio, è stato dimostrato che il tai-chi previene il Parkinson». Una delle critiche più frequenti alle medicine “alternative” è che queste funzionano solo come placebo. Ma, secondo Magi, il linguaggio tradizionale asiatico dovrebbe essere tradotto nel linguaggio medico occidentale: «Il chi, o energia vitale, per esempio, potrebbe essere tradotto con “rilascio di endorfine”».
Ma l’iniziativa dell’ospedale di Merano non ha suscitato solo commenti entusiastici. Anche se i pazienti pagheranno il 70% di questi trattamenti, la regione, per far partire l’iniziativa, ha dovuto stanziare un milione di euro. Secondo l’oncologo Francesco Cognetti, direttore del dipartimento di oncologia al Regina Elena di Roma, «in un momento in cui mancano le risorse per offrire ai malati i nuovi farmaci antitumorali è assurdo pensare alle medicine alternative. Che non hanno ancora dato prova scientifica definitiva della loro efficacia». Di parere diverso è invece il chirurgo oncologo Giorgio Pizzocaro, che pensa che «il medico deve essere aperto a tutto». «Quello di cui dobbiamo preoccuparci – spiega il medico – è che la sperimentazione sia fatta nel modo adeguato, poi non dobbiamo fare altro che aspettare i risultati. Dobbiamo ricordarci che la medicina si basa sull’evidenza».
Comunque il professor Magi si augura che la tradizione orientale sia presa in considerazione anche per agire sull’umore dei pazienti: «Dobbiamo uscire dalla concezione meccanicista figlia del pensiero occidentale ottocentesco. Agire sull’umore vuol dire rafforzare il sistema immunitario e migliorare la qualità della vita». Se la sperimentazione porterà dei risultati positivi, le cure alternative saranno utilizzate anche su altre patologie. Milioni di persone le usano, già oggi, contro diverse malattie mentali. Dobbiamo ricordarci che la depressione è stata definita la peste del nuovo millennio e che, secondo diversi studi, pare che tra pochi anni una persona su tre farà uso di psicofarmaci.
[andrea torrente]
continua
alle
19.1.09
0
commenti
![]()
Etichette: salute
ANNIVERSARI
I cento anni del secolo della velocità «Abbiate fiducia nel progresso che ha sempre ragione anche quando ha torto perché è movimento, vita, lotta, speranza», così diceva Filippo Tommaso Marinetti. L’importante è muoversi, correre e costruire. Parole in libertà, scordarsi il passato, vivere in un eterno presente di progresso come avanguardia dell’avanguardia stessa. A un secolo esatto da quel 20 febbraio 1909, quando l’editoriale de Le Figaro pubblicava il manifesto del movimento futurista, il flusso del divenire della velocità sembra non essersi ancora fermato. Anzi, il panorama culturale italiano prepara un anno di passione futurista.
«Abbiate fiducia nel progresso che ha sempre ragione anche quando ha torto perché è movimento, vita, lotta, speranza», così diceva Filippo Tommaso Marinetti. L’importante è muoversi, correre e costruire. Parole in libertà, scordarsi il passato, vivere in un eterno presente di progresso come avanguardia dell’avanguardia stessa. A un secolo esatto da quel 20 febbraio 1909, quando l’editoriale de Le Figaro pubblicava il manifesto del movimento futurista, il flusso del divenire della velocità sembra non essersi ancora fermato. Anzi, il panorama culturale italiano prepara un anno di passione futurista.
«È dall’Italia che lanciamo questo manifesto di violenza travolgente e incendiaria col quale fondiamo oggi il futurismo». Diceva bene la chiusura del manifesto del 1909, dall’Italia alla conquista del mondo, a cavallo della modernità in quella diatriba che l’Ottocento si era trascinato con lo scontro tra Romanticismo Neoclassicismo. Un’esplosione demolitrice che aveva spazzato via i cocci del XIX secolo, e che dal Belpaese, di cui rinnegava il patrimonio artistico culturale, approdò fino alle lande russe ispirando il genio di Vladimir Majakovskij e di Velimir Khlebnikov.
È comunque riduttivo rileggere il Futurismo solo con gli occhi del mito del progresso o come un rigurgito rivoluzionario artistico. Futurismo è, si dice bene, un movimento riformatore a tutto tondo. Se la storia dell’arte riporta gli scontri tra Marinetti e Apollinaire nella sovrapposizione del cubismo a matrice futurista, la risposta allo scontro si trova proprio nella capacità di estensione che il movimento ebbe in tutti i gangli dell’universo artistico, fino all’estremizzazione del modus vivendi incarnato in Balla. Il futurista vive da futurista e non si limita a praticare solamente una tecnica plastico-artistica. Cubista fu la tecnica, futurista il modo di vivere questa tecnica di scomposizione dell’oggetto nelle sue parti fino alla ripetizione del modulo grafico. Letteratura, pittura, scultura e architettura sono solo una porzione di quanto fu il futurismo, basti pensare al genio gastronomico di Jules Maincave e al suo manifesto della cucina futurista, fondato sull’accostamento di nuovi sapori mai sperimentati.
Per rispolverare le gesta di uomini che, partendo dall’arte, si posero l’obiettivo di cambiare il mondo, l’anno futurista italiano si inaugura con la pubblicazione del volume di Emilio Gentile La nostra sfida alle stelle. Futuristi in politica per poi aprire i battenti con una serie di eventi di grande rilevanza come le celebrazioni al Mart di Rovereto, città natale di Fortunato Depero. L’iniziativa Futurismo 100, patrocinata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che abbraccerà, oltre che Rovereto, anche Milano e Venezia, parte con l’inaugurazione della mostra curata da Ester Coen al Mart Illuminazioni. Avanguardie a confronto. Italia-Germania-Russia proprio presso la città tridentina per poi spostarsi a Venezia al Correr con Astrazioni e a Palazzo Reale a Milano con Simultaneità. Se l’esposizione trentina si pone l’obiettivo di creare un corridoio comunicativo tra le avanguardie europee dall’Italia alla Russia, il Correr di Venezia (dal 5 giugno) proporrà il dialogo tra Mondrian, Balla, e Picabia, mentre Milano (dal 15 ottobre) si concentrerà sul Boccioni, scultore in relazione con Archipenko, Brancusi e Pevsner. Ma non c’è solo arte nelle corde di questo centenario. Alle Stelline di Milano (dal 12 febbraio) sono in mostra le tavole delle parole libere di Marinetti tra cui la più grande mai esposta, Bombardment d’Andrinolpe di proprietà dell’Università di Los Angeles.
[francesco cremonesi]
continua
alle
19.1.09
0
commenti
![]()
Etichette: mostre
TRASPORTO SOSTENIBILE
Premiati Ecopass e BikeMi «È un onore per Milano ricevere un prestigioso riconoscimento internazionale per il proprio impegno a favore della mobilità sostenibile e dell’ambiente». Così Edoardo Croci, l’assessore alla mobilità, trasporti e ambiente del comune di Milano, commenta la menzione d’onore che la città ha ricevuto dalla Sustainable transport award commettee.
«È un onore per Milano ricevere un prestigioso riconoscimento internazionale per il proprio impegno a favore della mobilità sostenibile e dell’ambiente». Così Edoardo Croci, l’assessore alla mobilità, trasporti e ambiente del comune di Milano, commenta la menzione d’onore che la città ha ricevuto dalla Sustainable transport award commettee.
La commissione fa parte dell’Institute for transportation & development policy, un’organizzazione nata nel 1985 e diventata leader nella promozione dello sviluppo sostenibile.
Ogni anno l’istituto, oltre al premio per la città che ha raggiunto i migliori risultati nell’ambito del trasporto sostenibile, assegna diverse menzioni d’onore alle realtà cittadine fortemente impegnate nel settore. Milano ha ottenuto tale riconoscimento per i servizi ecopass e bike sharing, mentre il vincitore dell’edizione 2009 è New York City.
La menzione d’onore serve alla giunta Moratti per ribadire la bontà dell’ecopass e per rafforzare la proroga del provvedimento fino alla fine 2009. Per l’amministrazione comunale il riconoscimento è una vera e propria boccata d’ossigeno: dagli ultimi dati disponibili, infatti, si scopre che l’efficacia dell’ecopass sta diminuendo sempre più.
Durante il 2008, si è registrata una netta riduzione del numero dei veicoli in entrata nell’area ecopass: i dati aggiornati a settembre dello scorso anno evidenziano, infatti, un calo di 22mila automobili. Come conseguenza sono scesi i valori delle polveri inquinanti, mentre sono aumentati i numeri del trasporto pubblico: 10mila posti in più disponibili negli orari di punta e 1300 nuove corse per tram e metro.
Questo andamento incoraggiante, però, si è arrestato con il nuovo anno. Il 2009 si apre con un primato negativo: la concentrazione del Pm10 è fuorilegge otto giorni su dieci. Gli esperti sottolineano anche l’aumento di 7mila auto nella zona ecopass. «Il motivo di questo peggioramento - spiega Enrico Fedrighini, capogruppo consiliare dei Verdi - è dovuto a un errato rinnovo dell’ecopass. Il comune, infatti, ha prorogato il permesso per la libera circolazione agli Euro4 diesel, più inquinanti di un euro0 benzina. Inoltre, non è stato considerato il fatto che le persone cambiano macchina. Rispetto a un anno fa,quindi, oggi circolano molti più veicoli Euro5 che non sono soggetti al ticket».
Non si può negare l’utilità dell’ecopass, ma per il futuro sono necessari provvedimenti urgenti per adeguare la misura alle nuove esigenze. La strada da seguire, per Fedrighini, è chiara:«Il primo passo è mantenere invariata l’area in cui applicare l’ecopass. Bisogna, però, imporre la tassa a tutte le vetture, anche quelle meno inquinanti». In un secondo momento, si potrà ampliare anche l’area soggetta all’ecopass. «Per attuare una misura del genere – precisa Fedrighini – bisogna prima potenziare il servizio pubblico. Per fare questo, però, servono finanziamenti che si possono ottenere solo facendo pagare a tutti i veicoli il biglietto ecopass».
Sembra un cane che si morde la coda, ma il capogruppo dei Verdi non ha dubbi: «Si può fare, basta solo avere un po’ di coraggio per prendere anche decisioni impopolari. All’inizio i cittadini non saranno felici, ma se vedranno effetti positivi allora cambieranno idea. Il problema vero è che la giunta ha paura di esporsi troppo. Il riconoscimento internazionale ottenuto da Milano è giusto e gratificante, ma forse quest’amministrazione non se lo meritava».
[daniela maggi]
continua
alle
19.1.09
0
commenti
![]()
SEGRETI MENEGHINI
Perché Milan l'è un gran Milan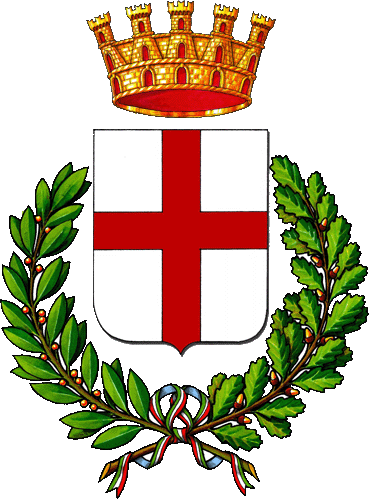 Si dice che i milanesi odino Milano: troppo grigia, troppo spenta, invivibile. Come tante dicerie, anche questa potrebbe non essere vera. Anzi, non lo è. Vere sono invece le storie, le cronache e le curiosità di Milano segreta, il libro scritto a quattro mani da Francesca Belotti e Gian Luca Margheriti, due giovani giornalisti che dal 2002 e per 6 anni hanno curato la rubrica omonima nella sezione Vivimilano del sito del Corriere della Sera.
Si dice che i milanesi odino Milano: troppo grigia, troppo spenta, invivibile. Come tante dicerie, anche questa potrebbe non essere vera. Anzi, non lo è. Vere sono invece le storie, le cronache e le curiosità di Milano segreta, il libro scritto a quattro mani da Francesca Belotti e Gian Luca Margheriti, due giovani giornalisti che dal 2002 e per 6 anni hanno curato la rubrica omonima nella sezione Vivimilano del sito del Corriere della Sera.
Il lavoro, presentato nella libreria Feltrinelli di corso Buenos Aires, è nato dallo sforzo di raccontare una Milano diversa, fatta di mille volti e di molti lati nascosti. In quanti sanno, per esempio, che sul tetto del Pirellone di Giò Ponti c’è una copia in miniatura della Madonnina del Duomo? Oppure che su una colonna del Palazzo della Regione c’è un bassorilievo che rappresenta la scrofa, simbolo di Milano? E ancora: chi sa che Albert Einstein ha passato l’infanzia nel cuore della città meneghina, e che qui ha gettato le basi di molte sue teorie, passeggiando per le vie del centro? Questi sono solo alcuni aneddoti contenuti e spiegati nel libro. Una guida, quindi, che si occupa non di letteratura e architettura in senso tradizionale, ma che racconta una storia nascosta, fatta di piccoli simboli che ancora oggi possiamo trovare nelle chiese e nelle strade.
«Milano ha una storia unica che non vuole sfruttare, perché vive proiettata nel futuro - dice Margheriti -. Per questo ci è sembrato doveroso suggerire una specie di percorso che possa far scoprire anche a chi vive in questa città, curiosità nascoste e interessanti che la rendano ancor più affascinante». Dal pubblico sale una domanda fra tutte: quali sono le fonti a cui gli autori hanno attinto per rivelare storie segrete di luoghi e persone? Belotti e Margheriti raccontano che il lavoro di ricerca si è sviluppato su libri e testi storici, ma determinante è stata la consultazione dei materiali d’archivio del Corriere della Sera. Un esempio: per ricostruire il “caso zanzara”, il giornalino del liceo Parini che fu oggetto di critiche e scandalo negli anni ’60, è stato consultato tutto il dibattimento del processo direttamente dagli atti che erano conservati nell’archivio.
Il pregio del libro è quello di aver fatto emergere in uno stesso luogo quello che sarebbe andato disperso o che sarebbe rimasto notizia solo per pochi; non a caso sembra quasi certo che ci sarà un seguito al volume. Certamente, da oggi, passeggiare per la Galleria Vittorio Emanuele sapendo che Buffalo Bill più di un secolo fa ci camminò dopo essersi esibito all’Arena nel Wild West Story, avrà tutto un altro sapore.
[cinzia petito]
continua
alle
19.1.09
0
commenti
![]()
CALCIO
Kakà-Milan, trattative pericolose Il contatto telefonico c’è già stato. L’incontro, autorizzato dal Milan, è fissato per lunedì. Il Manchester City (attraverso il suo agente Kia Joorabchian) incontrerà il papà-agente di Kakà per capire se esistono margini di trattativa per strappare la stella brasiliana ai rossoneri.
Il contatto telefonico c’è già stato. L’incontro, autorizzato dal Milan, è fissato per lunedì. Il Manchester City (attraverso il suo agente Kia Joorabchian) incontrerà il papà-agente di Kakà per capire se esistono margini di trattativa per strappare la stella brasiliana ai rossoneri.
Dal punto di vista tecnico è impossibile immaginare il Milan senza il suo giocatore più rappresentativo. Kakà ha già segnato 7 reti (con 2 rigori) in campionato ed è l’uomo a cui Ancelotti continua a chiedere gli straordinari. La sua cessione, però, non è pura utopia. Il Milan ha autorizzato l’incontro tra le parti e già questo è un segnale da non trascurare. C’è, poi, l’offerta del Manchester City: il presidente Mansour Bin Zahid Al Nahyan è disposto ad investire 100 milioni di euro (15 all’anno al calciatore) per mettere a disposizione del tecnico Hughes il rinforzo utile per abbandonare le secche della classifica (il Manchester City è quartultimo con 22 punti). È qui che il Milan, nonostante le smentite di facciata, traballa. Kakà è stato blindato quasi un anno fa con un rinnovo fino al 2013 (anno in cui compirà il 31simo compleanno) a 8 milioni di euro, ma l’offerta degli arabi è di quelle che fanno girare la testa. E il ragazzo, che del Milan vorrebbe diventarne una bandiera ed il capitano, non freme per andare via. Al futuro, però, è giusto pensare in tempo utile.
I citizens sono convinti di poter strappare Kakà al Milan. A incoraggiarli anche le dichiarazioni rilasciate ieri dal portavoce del brasiliano, Diogo Kotschko, che ha parlato «di operazione non impossibile. Se il Milan ci lascerà parlare, vedremo cosa il City ha da offrirci». «Speriamo ancora di prendere Kakà – ha dichiarato Marc Bowen, braccio destro di Hughes –. La situazione è stata una sorpresa per tutti ma ovviamente le trattative stanno andando avanti. Quanto vicini siamo non lo so, ma per quello che abbiamo capito c'è una forte possibilità che Kakà arrivi al Manchester City».
A luglio, poi, torneranno alla carica i blanchos. Florentino Perez cercherà di strapparlo al Milan per la terza estate consecutiva e, seppur restìo a cederlo ad una potenziale diretta concorrente in Europa, questa soluzione potrebbe essere più adatta per il Milan che segue con attenzione l’esplosione di Yaonn Gourcuff. Il talentino d’Oltralpe si sta affermando nel Bordeaux a cui i rossoneri lo hanno ceduto in prestito con diritto di riscatto (fissato a 15 milioni di euro) fino al termine della stagione. L’anno prossimo potrebbe essere quello giusto per riportare Gourcuff a Milanello a patto di garantirgli maggiore spazio. Una cosa è certa: l’erede di Zidane il prossimo anno giocherà «a Bordeaux o al Milan, ma non altrove». Adriano Galliani lo ha affermato all'Equipe pochi giorni fa ribadendo che «se il Bordeaux non pagherà il diritto di riscatto, Yoann tornerà da noi ed è escluso di darlo un'altra volta in prestito. È un giocatore eccellente e lo sta dimostrando con il Bordeaux e con la nazionale francese (6 presenze e un gol, ndr). Ci sarà spazio per lui al Milan».
[fabio di todaro]
continua
alle
16.1.09
0
commenti
![]()
CULTURA
Lella nel teatro delle meraviglie Si apre il sipario, ed ecco una semplice e nemmeno improbabile sceneggiatura teatrale. Bastano un palchetto, un tavolino e due bicchieri d’acqua. Il resto lo fa lei, come in tutte le sue rappresentazioni a teatro, le sue apparizioni in tv e le sue collaborazioni nei giornali. Lei che è capace di far ridere e piangere in scena esattamente come fa nella vita, dice. Lei che non vuole essere chiamata ex femminista, perché a suo modo continua ad esserlo: con orgoglio svela che dietro le quinte delle scene si circonda con dovizia di uomini validissimi. Ma rimane convinta che l’appartenenza a quel genere sessuale sia un deficit irreversibile. Lei è Lella Costa che, nella libreria Feltrinelli di piazza Piemonte, a Milano, ha presentato a una folla divertita e commossa, appunto, il suo ultimo libro Amleto, Alice e la Traviata. A farle da spalla, seduto comodamente al tavolino come fossero in un bar qualunque, c’era Michele Serra che, da collega e amico di vecchia data, ha coccolato Lella nelle pagine di prefazione e l’ha punzecchiata (ma tanto ha vinto lei) durante tutta l’intervista.
Si apre il sipario, ed ecco una semplice e nemmeno improbabile sceneggiatura teatrale. Bastano un palchetto, un tavolino e due bicchieri d’acqua. Il resto lo fa lei, come in tutte le sue rappresentazioni a teatro, le sue apparizioni in tv e le sue collaborazioni nei giornali. Lei che è capace di far ridere e piangere in scena esattamente come fa nella vita, dice. Lei che non vuole essere chiamata ex femminista, perché a suo modo continua ad esserlo: con orgoglio svela che dietro le quinte delle scene si circonda con dovizia di uomini validissimi. Ma rimane convinta che l’appartenenza a quel genere sessuale sia un deficit irreversibile. Lei è Lella Costa che, nella libreria Feltrinelli di piazza Piemonte, a Milano, ha presentato a una folla divertita e commossa, appunto, il suo ultimo libro Amleto, Alice e la Traviata. A farle da spalla, seduto comodamente al tavolino come fossero in un bar qualunque, c’era Michele Serra che, da collega e amico di vecchia data, ha coccolato Lella nelle pagine di prefazione e l’ha punzecchiata (ma tanto ha vinto lei) durante tutta l’intervista.
Lella Costa è una donna che ha dell’incredibile. Ripercorrendo la sua lunga carriera teatrale e riprendendo i soggetti del suo ultimo lavoro da scaffale, scarta personaggi mitici e universali come fossero caramelle: spiega e riesce, come sul palco, a raccontare di archetipi e storie eterne della nostra cultura senza annoiare. Con l’unica pretesa che non diventino una semplice parodia. « Il segreto è uno solo - dice -: conoscere davvero il testo, entrare in confidenza con la storia e immergersi in essa». La sua è una capacità tutta femminile: quella di chiacchierare e di aprire alle digressioni e ai rimandi d’attualità anche solidi nuclei teatrali, come sono le opere di Shakespeare. Così è per la carneficina finale dell’Amleto, per il dramma della lussuriosa e malata Margherita, che nella Traviata è costretta a lasciare il suo unico vero amore Alfredo, e per la continua inadeguatezza di Alice che si accompagna con il tempo che passa. La comicità di Lella è dilagante, ma è lei stessa ad ammettere che, in qualsiasi classico, è l’autore stesso che, pur inscenando il dramma, conserva un senso di rispetto e la voglia di sedurre costantemente il pubblico. «Insomma – racconta –, anche Shakespeare sapeva che dopo un po’ la sequenza verghiana delle sfighe e delle catastrofi diventa insopportabile e rischi l’effetto comico involontario!».
Prima di fare tutto questo, Lella Costa ogni volta sceglie l’opera che farà sua. Ma da cosa si fa guidare? Ci racconta che la scelta del testo nasce da una folgorazione. «Tutto nasce da un testo che ami, da un autore che ti incuriosisce e dalla sensazione che sia importante dire quella cosa e in quel momento, affinché rimanga valida per anni». Mica paglia, come direbbe lei, scusate. Per questo anche Stanca di guerra, messo in scena per la prima volta nel 1996 e riproposto negli anni fino a poco tempo fa, non è cambiato di una virgola. La guerra, adesso più di allora, rappresenta la nostra quotidianità. E il principio per cui questi classici sono ancora così vivi è il medesimo: parlano ancora di noi.
[cinzia petito]
continua
alle
15.1.09
0
commenti
![]()
LIBRI
Dialogo con i saggi dell’umanità: la scommessa di Tomatis Si inizia con una visione. La meraviglia di vette innevate e l’ombra di tre figure che, nel mezzo di un bagliore, risalgono un’esile cresta invisibile. Chi sono questi individui, di cui la brama di ascoltarne le parole supera qualsiasi altro desiderio? Si tratta di un terzetto dialogante, composto da Gesù, Socrate e Lao Tzu. Un accostamento quantomeno insolito, se non sperimentale, che, procedendo per analogia, prende il lettore per mano per condurlo verso un comune spirito superiore. Un dialogo che supera le barriere linguistiche tra gli interlocutori, ponendo su un piano analitico i punti di contatto e le differenze tra i dialoganti. È così che Francesco Tomatis, ordinario di filosofia teoretica dell’Università di Salerno, ha confrontato mediante lo strumento dialettico dell’analogia l’idealismo greco, la via maggiore di Tao e la parola di Gesù nel volume edito da Bompiani, Dialogo dei principi con Gesù, Socrate e Lao Tzu.
Si inizia con una visione. La meraviglia di vette innevate e l’ombra di tre figure che, nel mezzo di un bagliore, risalgono un’esile cresta invisibile. Chi sono questi individui, di cui la brama di ascoltarne le parole supera qualsiasi altro desiderio? Si tratta di un terzetto dialogante, composto da Gesù, Socrate e Lao Tzu. Un accostamento quantomeno insolito, se non sperimentale, che, procedendo per analogia, prende il lettore per mano per condurlo verso un comune spirito superiore. Un dialogo che supera le barriere linguistiche tra gli interlocutori, ponendo su un piano analitico i punti di contatto e le differenze tra i dialoganti. È così che Francesco Tomatis, ordinario di filosofia teoretica dell’Università di Salerno, ha confrontato mediante lo strumento dialettico dell’analogia l’idealismo greco, la via maggiore di Tao e la parola di Gesù nel volume edito da Bompiani, Dialogo dei principi con Gesù, Socrate e Lao Tzu.
Durante la lettura emerge però un interrogativo legato all’essenza stessa del processo analogico. Propria dell’analogia è la capacità di esaltare le vicinanze tra due elementi dimostrandone però accuratamente le differenze: «Riconosco che nella lettura di questo volume si possa correre il rischio della prevalenza della congiunzione nel processo analogico – spiega l’autore – . La passione verso gli autori mi ha portato all’esaltazione di queste affinità. Resta comunque l’analisi delle differenze tra i tre. Il Gesù che parla nel volume è quello di Giovanni, passato attraverso la lettura di Pareyson e Cacciari, mentre Socrate è assolutamente platonico. Lao Tzu invece è stato letto personalmente, grazie alla pratica delle arti marziali (Tomatis infatti è istruttore di Kung Fu ndr), filtrato quindi attraverso l’esperienza». Le distanze di cui parla Tomatis sono incarnate, per esempio, dalla lingua con cui Lao Tzu si esprime. Continua Tomatis: «Il suo linguaggio è fatto di ideogrammi, un elemento che, nella sua apparente scleroticità, riesce a rendere maggiore il senso del divenire proprio perché apre una visione più allargata della realtà». Nella struttura dialogica compare anche un quarto personaggio, Aurora, voce dell’uomo posto di fronte all’esperienza mistica: «La comunione delle posizioni avvicinate dagli interlocutori avviene attraverso Aurora, una sorta di Sofia biblica – continua l’autore – ; così, queste affinità si mostrano vicine non per comparazione o mediazione, quanto nell’occupare uno spazio dialogico superiore e indicibile».
L’operazione svolta da Tomatis, oltre che essere sicuramente coraggiosa, ha il pregio di percorrere il binario fondamentale dell’attività filosofica: la capacità di osare. «Il filosofo deve osare e per scrivere così come Tomatis serve audacia –lo dice il sindaco di Venezia, Massimo Cacciari, filosofo anche lui –. Le domande dell’uomo restano sempre quelle, e sono quelle che tutte le confessioni ci hanno posto: ecco, questo libro le mette di nuovo sul piatto e le espone con un linguaggio del tutto particolare. Filosofia non è osare per sciocca presunzione, perché non si ottiene mai una risposta definitiva». Il perché la speculazione filosofica sia tutta una scommessa, uno spingersi oltre, lo chiarisce Cacciari stesso. «Perché congiunge, cioè avvicina realtà diverse». E lo fa in vari modi, come nel caso di René Guinon che va alla ricerca delle fonti comuni da cui deriva tutta la storia del pensiero. Tomatis, invece, secondo Cacciari, «non dà voce a una tradizione bensì cerca queste affinità attraverso un esercizio di comparazione e analogia». Analizzando le scelte linguistiche di Tomatis, Cacciari risale il concetto di analogia con cui l’autore ha avvicinato i tre protagonisti dei dialoghi: «Tomatis procede per analogia e questa ci mostra come due realtà possano avvicinarsi anche senza incontrarsi mai, come, ad esempio, per l’amore rinascimentale o per l’amicizia stellare di Nietzsche». Continua Cacciari: «Gesù, infatti, parla da teologo: e questo Gesù teologo è il Gesù di Giovanni, a cui, d’altra parte, si sono sempre riferiti Hegel o Ratzinger. Ma il senso del logos evangelico, della “parola” di Giovanni, è diverso, da non confondersi assolutamente con il “pensiero”, il logos classico. Questo perché la concezione divina classica non ha nulla a che vedere con quella cristiana». In sostanza, un dio-logos e verbo, che si fa carne e che viene ad abitare in mezzo a noi, mette in luce la paradossalità e la forza stessa del cristianesimo.
[francesco cremonesi]
continua
alle
14.1.09
0
commenti
![]()
Etichette: libri
CINEMA
Will Smith, sette anime e sette vite Difficile identificare “Will, il principe di Bel Air” nell’uomo dal viso scavato che per 125 minuti ininterrotti è una maschera di dolore, rotta solo da qualche raro e tirato sorriso.
Difficile identificare “Will, il principe di Bel Air” nell’uomo dal viso scavato che per 125 minuti ininterrotti è una maschera di dolore, rotta solo da qualche raro e tirato sorriso.
Eppure, con Sette anime – nelle sale italiane a partire dal 9 gennaio – l’ormai 40enne Will Smith, nella sua ultima prova drammatica ha dimostrato tutta la maturità della sua esperienza. Conosciuto come attore di film e telefilm comici e d’azione, negli ultimi anni lo abbiamo visto cimentarsi con tematiche più impegnate, con personaggi immersi negli abissi dell’animo umano. Dopo La ricerca della felicità, che ha ribaltato la maschera comica di Mr. Smith, eccolo ora ripetere la collaborazione con Gabriele Muccino in Sette anime, secondo film americano del regista de L’ultimo bacio.
Il soggetto, curato da Grant Nieporte, ha come protagonista Ben Thomas, esattore del fisco. Questi si presenta a casa di alcune persone, documenti alla mano, per discutere delle loro tasse. Ma improvvisamente, tra una domanda d’argomento fiscale e l’altra, emerge che Thomas ha una profonda conoscenza dei problemi di chi gli sta di fronte. Non solo, ma sostiene di essere in grado di fare loro un dono speciale, che cambi il corso della loro vita. Ben Thomas - come guidato da una forza superiore, in realtà attanagliato da un rimorso angoscioso – si imbatte così in sette persone umili e nascoste ma di grande bontà e coraggio, che hanno bisogno d’aiuto ma non saprebbero a chi chiederlo. E, come per magia, consegna loro un messaggio di speranza e il dono risolutore. Ma chi è Ben Thomas, e cosa nascondono i suoi doni? Cosa accadrà, quando una ragazza cardiopatica – l’attrice Rosario Dawson - gli ruberà il cuore? L’amore e la responsabilità metteranno l’eroe protagonista di fronte a una tragica scelta.
È, questa, una pellicola che si cimenta con temi tipici della morale americana: un uomo, il suo senso di colpa, la responsabilità personale, l’espiazione, la scelta, il dono fatto a sette “brave persone” sconosciute. L’atmosfera di Sette anime è quella del thriller a stelle e strisce. La narrazione abbandona via via i toni inquietanti dell’esordio per assumere poi quelli delicati e malinconici. La trama, inizialmente di non facile comprensione, si ricompone come un puzzle dando man mano tutte le risposte fino alla conclusione, inevitabile e annunciata già nella prima scena. Vagamente inquietante, malinconico e solo apparentemente freddo è il personaggio interpretato da Will Smith, icona dell’eroe in cerca di redenzione. Nulla a che vedere con i divi italiani, impelagati in isteriche trame sentimentali, solitamente diretti da Muccino.
Non è un film da guardare a cuor leggero, questo; non a caso la critica si è divisa a riguardo. Il New York Magazine, per esempio, l’ha spedito in testa alla classifica dei dieci film più brutti del 2008. Per i critici del quotidiano newyorkese Sette anime è “grottesco”, “indigeribile”, “ovvio e falso”. Ma l’ultima parola come al solito, spetterà al pubblico e alla cifra totale degli incassi.
[floriana liuni]
continua
alle
14.1.09
0
commenti
![]()
Etichette: cinema
CITIZEN JOURNALISM
Ma che tempo che fa Un' Epifania così non si era mai vista. Per fare un regalo all'Italia, il maltempo la mette in ginocchio. E, al posto del carbone, la Befana seppellisce Milano di neve. Con gli inevitabili disagi: strade inagibili, trasporti impossibili, scuole chiuse. Nonostante le rassicurazioni delle autorità. E i cittadini non le mandano a dire. Di più: scrivono i loro messaggi ai siti dei maggiori quotidiani nazionali. Noi vi raccontiamo come gli italiani, da un'emergenza che sembrava banale, si siano ritrovati citizen journalists.
Un' Epifania così non si era mai vista. Per fare un regalo all'Italia, il maltempo la mette in ginocchio. E, al posto del carbone, la Befana seppellisce Milano di neve. Con gli inevitabili disagi: strade inagibili, trasporti impossibili, scuole chiuse. Nonostante le rassicurazioni delle autorità. E i cittadini non le mandano a dire. Di più: scrivono i loro messaggi ai siti dei maggiori quotidiani nazionali. Noi vi raccontiamo come gli italiani, da un'emergenza che sembrava banale, si siano ritrovati citizen journalists.
1. Siamo o non siamo tutti giornalisti?
2. Se la Befana mette nel sacco la tv
[alessia lucchese - andrea torrente]
continua
alle
14.1.09
0
commenti
![]()
Etichette: dossier, giornalismo, milano



















